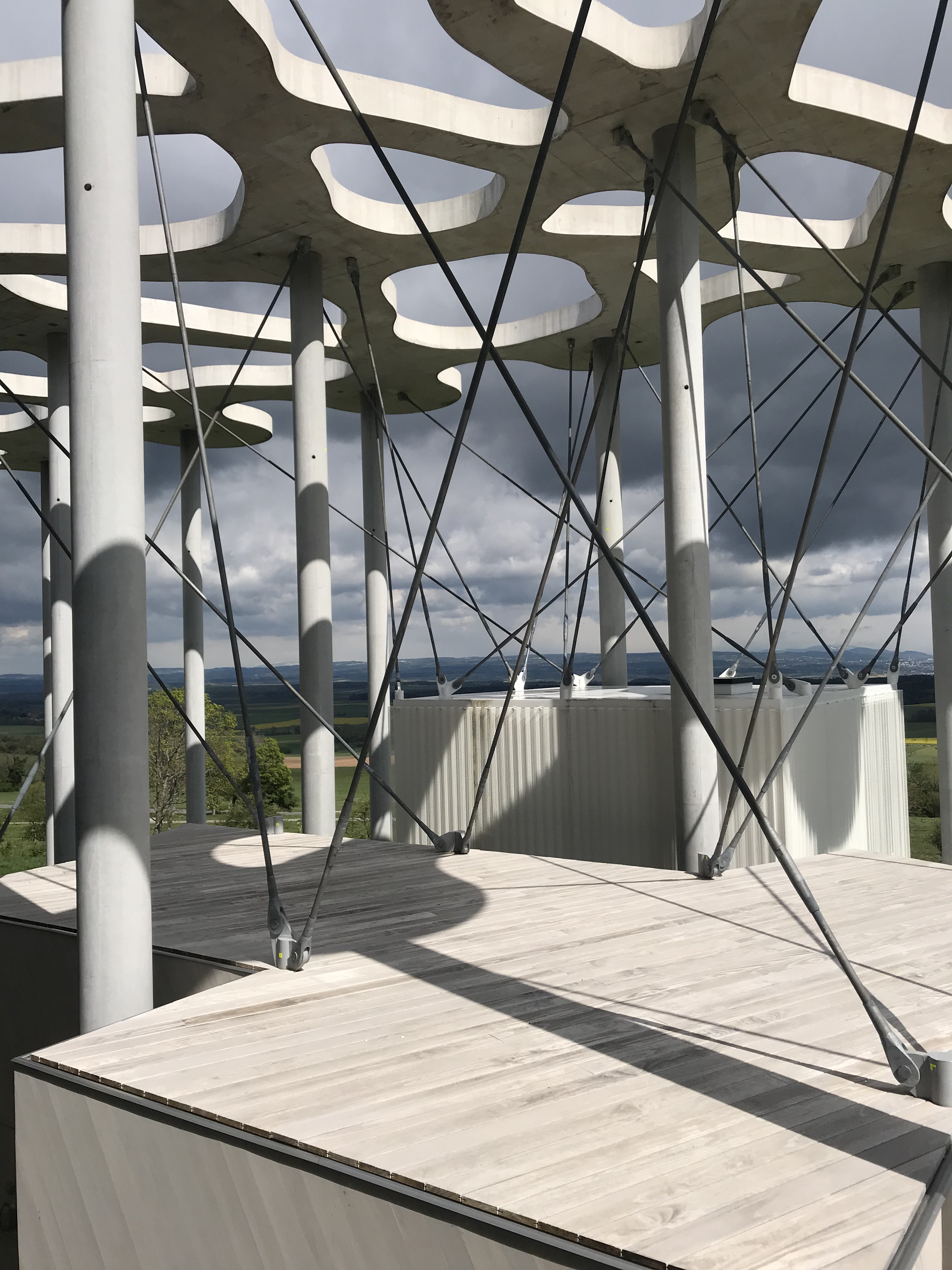Le proteste, esplose al grido Black Lives Matter, slogan che non dovrebbe neppure esistere per la sua incontrovertibile ovvietà, oltre a scatenare la reazione popolare quasi ovunque negli Stati Uniti e in Europa, hanno portato con sé un fenomeno che fin dall’antichità era riservato in genere contro ciò che evocava il potere ostile. Mutilare o distruggere una statua, infatti, come gesto di ribellione e disobbedienza civile, oggi si è caricato di una nuova sfumatura ed è stato applicato a monumenti che celebrano personaggi legati ad un passato coloniale e razzista, che, in questo modo, si pensa possa essere se non cancellato, almeno purgato.
Un gesto che finora aveva accompagnato tanto l’atto finale e violento di molti regimi; quanto la presunta iconoclastia, spesso mossa propagandistica e non certo di carattere teologico.
L’episodio dell’abbattimento della statua di Edward Colston a Bristol, portato a termine violentemente dalla folla al culmine di una protesta anti razzista, ha scatenato un incredibile numero di commenti e può essere letto in molti modi differenti.
Innanzitutto, perché quella statua campeggiava nel centro della città inglese? La risposta è data dalla storia. Edward Colston (1636 – 1721) fu, infatti, ai suoi tempi, un filantropo e un benefattore, tanto che ancora oggi la Dolphin Societies, una delle più antiche società di mutuo soccorso a Bristol, si occupa del sostegno e soccorso di anziani e disabili… Peccato che il mercante avesse il vizietto, del tutto legale all’epoca, di trafficare schiavi dall’Africa. Quando la statua fu collocata, come monumento con funzione evocativa, riconosceva al personaggio un’importanza, in questo caso sociale, il cui ricordo a distanza di secoli è scemato, dimenticato, o è divenuto addirittura offensivo. È il corso della storia. E come la statua di Colston, frutto di un’epoca, ci sono centinaia di statue che commemorano personaggi che col tempo sono divenuti scomodi o impresentabili. Il dibattito verte allora su cosa pensare di tutto ciò. Se sia lecito o meno dare un colpo di spugna a un passato vergognoso, cancellando gli errori e gli orrori della storia o piuttosto la strada giusta sia la contestualizzazione che aiuti a comprendere, non a scusare, questa storia. Il dibattito naturalmente è rovente.
C’è chi come l’architetto e fotografo Antonio Ottomanelli afferma che l’atto di distruzione della statua in questione è da difendere, argomentando che “La città consiste di un sistema di significati fissati su di un territorio e la memoria è quella forma di linguaggio che usa questi significati. L’azione ed il movimento usano il linguaggio della memoria. Per questo è indispensabile tutelare il diritto all’azione libera, l’imprevedibilità del movimento, per difendere i meccanismi e i contenuti della memoria. La memoria insieme al movimento sono le sostanze che rendono possibile ogni forma di relazione permettendo la conseguente formazione di ideologie, mentre l’imprevedibilità genera lo spazio pubblico. L’ideologia incontra lo spazio pubblico per creare nuove comunità. Questo incontro può anche avvenire in maniera conflittuale e violenta, fissando significati drammatici sul territorio e tragedie nella memoria collettiva“. (Art Tribune) Dunque la rimozione della statua di Colston, è entrata ora a far parte della storia di Bristol e come tale si potrebbe accettare la proposta provocatoria di Banksy:
“We drag him out the water, put him back on the plinth, tie cable round his neck and commission some life size bronze statues of protestors in the act of pulling him down. Everyone happy. A famous day commemorated.”
Oppure c’è chi come Pedro Azara, curatore del padiglione della Catalogna alla biennale 2019, Catalonia in Venice—To Lose Your Head (Idols), incentrato proprio su questo tema, afferma “queste azioni indicano il potere delle immagini e la loro capacità di metterci di fronte ai fantasmi della storia. Generalmente viene sfigurato il volto delle statue, specialmente gli occhi, in modo da negare loro la forza dello sguardo, altre volte vengono macchiate con colore o scritte, altre volte mutilate”. Tutto quello che non si accetta si elimina: un’attitudine repressiva e ignorante. Però la storia rimane. Che ci piacciano o no, i fatti e gli eventi sono successi, che suscitino vergogna, indignazione o simpatia. Ed è sempre una storia di vincitori e vinti –anche se a volte non si sa bene chi è chi, per questo la storia deve essere raccontata, spiegata, senza doverla giustificare, fornendo tutte le “armi” interpretative necessarie per conoscere e comprendere quello che è successo. L’oblio forzato che si pratica oggi è un errore tragico – con conseguenze imprevedibili. La distruzione di testimonianze moleste impedisce qualsiasi valutazione critica. Negando la conoscenza ci muoviamo come se fossimo ciechi – un procedimento abituale nelle dittature, dove si tergiversa la storia, con una narrazione che difficilmente scappa al controllo e alla manipolazione. Per questo, qualsiasi elemento, documento, testo o immagine che può aiutare a “mettere in prospettiva” la storia, per vederla meglio, con tutte le sue contraddizioni, deve essere difeso e promosso. Una statua soppressa o distrutta è un buco nero nella trama della storia”. (Art Tribune)
Non esiste una risposta univoca, ognuno deve trovarne una che soddisfi la sensibilità personale. Nel nostro piccolo abbiamo chiesto il parere di una giovane gallerista e di una storica dell’arte.
Fiammetta Poggi, della Galleria Accaventiquattro di Prato, ci dice “Onestamente ho dei pensieri contrastanti… Se da una parte è giusto commemorare la memoria storica, dall’altra é anche vero che alcune di queste commemorazioni sono state fatte su personaggi che hanno avuto un passato discutibile (vedi Montanelli, anche se sappiamo bene tutti che spesso il genio é accompagnato da un passato turbolento).
La mia domanda é a monte: perché si sono fatte statue su certi personaggi? E ancora… E così importante continuare a fare statue su personaggi illustri? Non sarebbe meglio commemorarli in altro modo?
L’unica nota positiva in tutto ciò, é la bellezza rivoluzionaria delle persone, ancora disposte a combattere per degli ideali”
Stefania Gori, storica dell’arte pratese, da parte sua commenta: “Mi è stato chiesto cosa pensassi delle statue abbattute. Il mio ricordo è andato subito alla statua di Stalin che fu abbattuta nel 2010 in Georgia e poi a quella di Saddam Hussein nel 2003, infine a quando i talebani distrussero le celebri statue di Budda a Bamyan, in Afghanistan (2001) . Si cancellano le tracce del passato con furia e per rabbia, per rancore, ma il passato ce lo portiamo addosso. Non si può cancellare la storia, meglio saperla interpretare; per voltare pagina davvero l’unico modo è leggerla con gli occhi di oggi. Cosa mi auguro? Più incarichi pubblici per gli artisti in modo da lasciare tracce contemporanee nelle piazze , sui muri dei nostri edifici. Gli artisti da sempre sanno graffiare e demolire più delle pietre: a loro lascerei la parola“.
Il passato non si cancella, ma si impara a riconoscerne le ombre, soprattutto quelle che ha gettato sul presente. L’unica via per non prendere una china pericolosa e arrivare a fare patti con la storia, anche quella più buia, cercare di contestualizzare criticamente quello che essa ci ha lasciato.